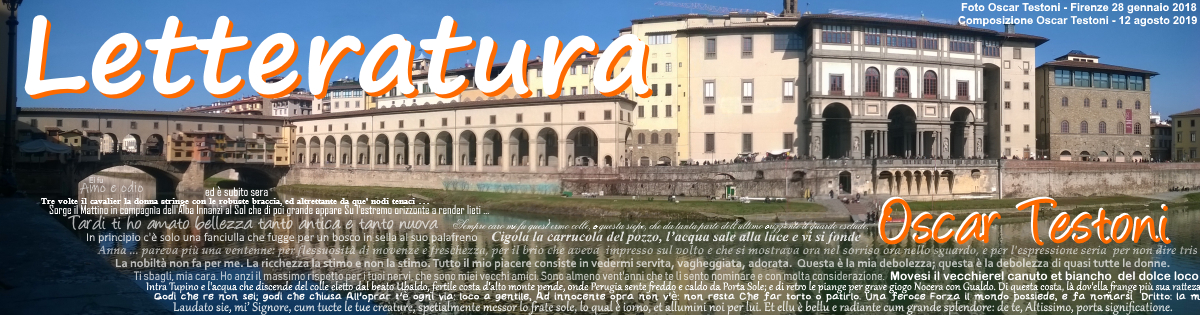|
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
-
O
s
c
a
r
T
e
s
t
o
n
i
|
La "noia", parola che nell'italiano antico ha un significato più attivo e forte, quello di tormento, fastidio e dolore (si pensi all'uso in Dante: perché ritorni a tanta noia - si veda in Enciclopedia datesca) e nell'italiano colloquiale molto più debole di disinteresse nei confronti delle attività o discorsi in cui si è inseriti, in Leopardi assume il senso di avvertimento o di presa di coscienza di una mancanza di senso della vita dell'uomo e quindi di infelicità, di quel male di vivere , come lo chiamerà Montale, che si inserisce in quella inquietudine che dalla melancholìa aristotelica, passando per la strenua inertia o il funestus veternus oraziano, l'akedia tomistica e petrarchesca, arriva allo spleen di Baudelaire e appunto al male di vivere di Montale.
La prima annotazione sulla noia nel suo Zibaldone (raccolta di suoi pensieri e appunti dal luglio 1817 al dicembre 1832) risale al 30 settembre 1821, dove la noia viene definita come una passione , figlia della nullità e madre del nulla , non solo sterile in sé, ma capace di rendere sterile tutto ciò che si mescola, si avvicina o abbia a che fare con la noia.
Nell'ottobre del '23, l'analisi di questa passione si affina nel determinarne la natura, attraverso considerazioni che si rifanno alla concezione sensistica del piacere. L'assenza sia del piacere che del diapiacere è noia, che come l'aria, occupa tutti gli interstizi lasciati vuoti negli animi umani dal piacere e dal dispiacere: un'assenza di passioni, che è però a sua volta una passione. L'animo umano non può non desiderare la felicità (o il piacere) e quando questo desiderio non è soddisfatto (o contrastato da un dolore) prova la noia. Nasce così qui una prima definizione che cerca di coglierne la natura: La noia è il desiderio della felicità, lasciato, per così dir, puro.
Il 13 novembre 1823 Leopardi ritorna sull'aspetto di noia come assenza di passione, che è però a sua volta una passione, proprio per accentuarne quest'ultimo aspetto, di qualcosa di vivo, sensibile e intenso, distanziandosi dall'accezione comune. Essa, pur confermandosi nella sua natura di desiderio di felicità lasciato puro , ribadendo la definizione dell'autore del mese precedente, si avvicina in modo più chiaro all'infelicità . Coerentemente con l'analisi sensistica del piacere operata in ottobre, Leopardi attribuisce questo stato principalmente ai giovani, che hanno un desiderio di felicità e di piacere molto più vivo.
Ma è l'8 marzo 1824 il momento in cui Giacomo Leopardi nel suo Zibaldone scoperchia in modo più evidente le radici di questa passione, scoprendone quella che per lui è l'essenza profonda e ultima di quell'inquietudine interiore che lui chiama noia : la semplice vita pienamente sentita, provata, conosciuta, pienamente presente all'individuo, ed occupantelo . In questa fase dello sviluppo del suo pensiero, la vita è un male e averne pieno avvertimento è provare, sentire, vivere questo male che è la vita. Chi è distratto o si diverte non è più felice, semplicemente avverte meno l'essenza della vita e quindi è meno infelice, non perché abbia un bene in più, ma perché avverte meno il male insito nella sua esistenza.
Dunque, come dirà nell'annotazione del 4 maggio 1829, la noia è senire, in assenza di bene o di male, l'infelicità nativa dell'uomo . Questa sola basterebbe a piegare la bilancia della vita umana dalla parte dell'infelicità, anche se i mali patiti dall'uomo non fossero superiori ai suoi beni.
Esprimono probabilmente un posizione successiva del pensiero del Leopardi i due pensieri LXVII e LXVIII nei quali l'autore differenzia l'essere disoccupato, o sfaccendato dall'essere annoiato e attribuisce la noia alle persone dotate di uno spirito maggiore rispetto agli altri che facilmente si distraggono o provano diletto a causa di una qualunque occupazione. Per questo gli uomini di sentimento non vengono compresi o vengono addirittura derisi quando parlano della noia come uno dei mali maggiori e più inevitaili della vita . Addirittura la noia diventa il più sublime dei sentimenti umani , perché è il maggior segno di grandezza e di nobiltà di chi la prova. Cos'è infatti la noia se non il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, nè, per dir così dalla terra intera ? Essere in grado di considerare l'infinito universo e sentire che il proprio animo e il proprio desiderio sono ancora più grandi di tale universo, e che questo universo non potrà mai riempire il proprio animo e il proprio desiderio è appunto segno di tale grandezza e nobiltà. Gli uomini dappoco conoscono poco la noia, gli animali pochissimo.
TO BE CONTINUED
|
TESTI:
La noia è la più sterile delle passioni umane. Com'ella è figlia della nullità, così è madre del nulla: giacché non solo è sterile per se, ma rende tale tutto ciò a cui si mesce o avvicina ec. (30 Settembre 1821)
Alla p. 3622. L�idea e natura della quale esclude essenzialmente s� quella del piacere che quella del dispiacere, e suppone l�assenza dell�uno e dell�altro; anzi si può dire la importa; giacché questa doppia assenza è sempre cagione di noia, e posta quella, v�é sempre questa. ( 3714 ) Chi dice assenza di piacere e dispiacere, dice noia, non che assolutamente queste due cose sieno tutt�una, ma rispetto alla natura del vivente, in cui l�una senza l�altra (mentre ch�ei sente di vivere) non può assolutamente stare. La noia corre sempre e immediatamente a riempiere tutti i vuoti che lasciano negli animi de� viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo stato d�indifferenza e senza passione, non si dà in esso animo, come non si dava in natura secondo gli antichi. La noia è come l�aria quaggi�, la quale riempie tutti gl�intervalli degli altri oggetti, e corre subito a stare là donde questi si partono, se altri oggetti non gli rimpiazzano. O vogliamo dire che il vuoto stesso dell�animo umano, e l�indifferenza, e la mancanza d�ogni passione, è noia, la quale è pur passione. Or che vuol dire che il vivente, sempre che non gode né soffre, non può fare che non s�annoi? Vuol dire ch�e� non può mai fare ch�e� non desideri la felicità, cioè il piacere e il godimento. Questo ( 3715 ) desiderio, quando e� non è né soddisfatto, né dirittamente contrariato dall�opposto del godimento, è noia. La noia è il desiderio della felicità, lasciato, per cos� dir, puro. Questo desiderio è passione. Quindi l�animo del vivente non può mai veramente essere senza passione. Questa passione, quando ella si trova sola, quando altra attualmente non occupa l�animo, è quello che noi chiamiamo noia. La quale è una prova della perpetua continuità di quella passione. Che se ciò non fosse, ella non esisterebbe affatto, non ch�ella si trovasse sempre ove l�altre mancano (17 ottobre 1823). Vedi p. 3879.
Alla p. 3715. Sono molte volte che la noia è un non so che di pi� vivo, che ha pi� sembianza perciò di passione, e quindi avviene che non sia sempre in tali casi chiamata noia, benché filosoficamente parlando, ella lo sia, consistendo in quel medesimo in cui consiste quel che si chiama noia, cioè nel desiderio di felicità lasciato puro, senza infelicità né felicità positiva, e differendo solo nel grado da quella che noia comunemente è chiamata. E differisce nel grado, in quanto ell�é noia, in certo modo pi� intensa, sensibile e viva, qualità che l�avvicinano all�infelicità cos� chiamata positivamente, e che paiono poco convenevoli alla noia. Ella infatti, benché del genere stesso, è pi� passione è pi� penosa, che la noia, cos� comunemente chiamata, non è. Ed è tale perch�ella nasce e consiste in un desiderio pi� vivo, e al tempo stesso ugualmente vano. Questa sorta di passione è quella che provano generalmente i giovani quando sono in istato di non piacere e non dispiacere. Essi sono poco capaci della noia comunemente detta. Essi sono poco capaci di trovarsi giammai senza un�attuale, ancorché indeterminata passione,[1] pi� viva d�essa noia, perché il loro amor proprio, e quindi il lor desiderio di felicità e di piacere, ugualmente vano che nell�altre età, è molto pi� vivo, generalmente parlando. Incapaci di noia comunemente detta, benché privi di piacere e dispiacere, sono ancora similmente quegli stati dell�individuo, di cui ho detto p. 3835-6.3876-8. e simili. Altres� lo stato di desiderio presente e vivo determinato a qual si sia cosa; benché privo anche questo stato, di piacere e dispiacere positivo ec. E cos� discorrendo. Questa sorta di passione, diversa dalla noia comunemente detta, ma dello stesso genere ec., questa ancora io voglio comprendere sotto il nome di noia, e ad essa ancora si deve intendere ch�io abbia riguardo quando affermo che la noia corre immancabilmente e immediatamente a riempiere qualunque vuoto lasciato dal piacere o dispiacer cos� detto ec. e che l�assenza dell�uno e dell�altro è noia per sua natura, e che mancando essi, v�é la noia necessariamente, e che posta tal mancanza è posta la noia ec. come alle p. 3713-5 (13 novembre 1823).
Né la occupazione né il divertimento qualunque, non danno veramente agli uomini piacere alcuno. Nondimeno è certo che l'uomo occupato o divertito comunque,
è manco infelice del disoccupato, e di quello che vive vita uniforme senza distrazione alcuna. Perché? se né questi né quelli sono punto superiori gli uni agli
altri nel godimento e nel piacere, ch'è lo unico bene dell'uomo? Ci� vuol dire che la vita è per se stessa un male. Occupata o divertita, ella si sente e si conosce meno, e passa, in apparenza più presto, e perciò solo, gli uomini occupati o divertiti, non avendo alcun bene né piacere più degli altri, sono però manco infelici: e gli uomini disoccupati e non divertiti, sono più infelici, non perché abbiano minori beni, ma per maggioranza di male, cioè maggior sentimento, conoscimento, e diuturnità (apparente) della vita, benché questa sia senza alcun altro male particolare. Il sentir meno la vita e l'abbreviarne l'apparenza è il sommo bene, o vogliam dire la somma minorazione di male e d'infelicità, che l'uomo possa conseguire. La noia è manifestamente un male, e l'annoiarsi una infelicità. Or che cosa è la noia? Niun male né dolore particolare (anzi l'idea e la natura della noia esclude la presenza di qualsivoglia
particolar male o dolore) ma la semplice vita pienamente sentita, provata, conosciuta, pienamente presente all'individuo, ed occupantelo. Dunque la vita è semplicemente un male: e il non vivere, o il viver meno, sì per estensione che per intensione, è semplicemente un bene, o un minor male, ovvero preferibile per se ed assolutamente alla vita ec. (8 Marzo 1824). Vedi p. 4074.
L'assenza di ogni special sentimento di male e di bene, ch'è lo stato più ordinario della vita, non è né indifferente, né bene, né piacere, ma dolore e male. Ciò solo, quando d'altronde i mali non fossero più che i beni, né maggiori di essi, basterebbe a piegare incomparabilmente la bilancia della vita e della sorte umana dal lato della infelicità. Quando l'uomo non ha sentimento di alcun bene o male particolare, sente in generale l'infelicità nativa dell'uomo, e questo è quel sentimento che si chiama noia. (4. Maggio. 1829 - Zib. 4498).
"Poco propriamente si dice che la noia è mal comune . Comune è l'essere disoccupato, o sfaccendato, per dir meglio; non annoiato. La noia non è se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può lo spirito in alcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile. la massima parte degli uomini trova bastante occupazione in che che sia, e bastante diletto in qualunque occupazione insulsa; e quando è del tutto disoccupata, non prova perciò gran pena. Di qui nasce che gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la noia, e fanno il volgo talvolta maravigliare talvolta ridere, quando parlano della medesima e se ne dolgono con quella gravità di parole, che si usa in proposito dei mali maggiori e più inevitabili della vita"
(Pensieri, LXVII)
"La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall'esame di tale sentimento nascano quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma nondimeno il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena , né, per dir così dalla terra intera, considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l'universo infinito, e sentire che l'animo ed il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d'insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e nobiltà, che si veggia nella natura umana. perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali"
(Pensieri, LXVIII)
XXIII - CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL'ASIA
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore;
Move la greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
L'ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s'affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov'ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.
Nasce l'uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell'esser nato.
Poi che crescendo viene,
L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell'umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
Perché reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura
Perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
E forse del mio dir poco ti cale.
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
Che sì pensosa sei, tu forse intendi,
Questo viver terreno,
Il patir nostro, il sospirar, che sia;
Che sia questo morir, questo supremo
Scolorar del sembiante,
E perir dalla terra, e venir meno
Ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
Il perché delle cose, e vedi il frutto
Del mattin, della sera,
Del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
Rida la primavera,
A chi giovi l'ardore, e che procacci
Il verno co' suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
Che son celate al semplice pastore.
Spesso quand'io ti miro
Star così muta in sul deserto piano,
Che, in suo giro lontano, al ciel confina;
Ovver con la mia greggia
Seguirmi viaggiando a mano a mano;
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
Smisurata e superba,
E dell'innumerabile famiglia;
Poi di tanto adoprar, di tanti moti
D'ogni celeste, ogni terrena cosa,
Girando senza posa,
Per tornar sempre là donde son mosse;
Uso alcuno, alcun frutto
Indovinar non so. Ma tu per certo,
Giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
Che degli eterni giri,
Che dell'esser mio frale,
Qualche bene o contento
Avrà fors'altri; a me la vita è male.
O greggia mia che posi, oh te beata,
Che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d'affanno
Quasi libera vai;
Ch'ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe,
Tu se' queta e contenta;
E gran parte dell'anno
Senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra,
E un fastidio m'ingombra
La mente, ed uno spron quasi mi punge
Sì che, sedendo, più che mai son lunge
Da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
E non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
Non so già dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
O greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
A bell'agio, ozioso,
S'appaga ogni animale;
Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale?
Forse s'avess'io l'ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all'altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dì natale.
DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE
Genio. Come stai Torquato?
Tasso. Ben sai come si può stare in una prigione, e dentro ai guai fino al collo.
Genio. Via, ma dopo cenato non è tempo da dolersene. Fa buon animo, e ridiamone insieme.
Tasso. Ci son poco atto. Ma la tua presenza e le tue parole sempre mi consolano. Siedimi qui accanto.
Genio. Che io segga? La non è già cosa facile a uno spirito. Ma ecco: fa conto ch'io sto seduto.
Tasso. Oh potess'io rivedere la mia Leonora. Ogni volta che ella mi torna alla mente, mi nasce un brivido di gioia, che dalla cima del capo mi si stende fino all'ultima punta de' piedi; e non resta in me nervo né vena che non sia scossa. Talora, pensando a lei, mi si ravvivano nell'animo certe immagini e certi affetti, tali, che per quel poco tempo, mi pare di essere ancora quello stesso Torquato che fui prima di aver fatto esperienza delle sciagure e degli uomini, e che ora io piango tante volte per morto. In vero, io direi che l'uso del mondo, e l'esercizio de' patimenti, sogliono come profondare e sopire dentro a ciascuno di noi quel primo uomo che egli era: il quale di tratto in tratto si desta per poco spazio, ma tanto più di rado quanto è il progresso degli anni; sempre più poi si ritira verso il nostro intimo, e ricade in maggior sonno di prima; finché durando ancora la nostra vita, esso muore. In fine, io mi maraviglio come il pensiero di una donna abbia tanta forza, da rinnovarmi, per così dire, l'anima, e farmi dimenticare tante calamità. E se non fosse che io non ho più speranza di rivederla, crederei non avere ancora perduta la facoltà di essere felice.
Genio. Quale delle due cose stimi che sia più dolce: vedere la donna amata, o pensarne?
Tasso. Non so. Certo che quando mi era presente ella mi pareva una donna; lontana, mi pareva e mi pare una dea.
Genio. Coteste dee sono così benigne, che quando alcuno vi si accosta, in un tratto ripiegano la loro divinità, si spiccano i raggi d'attorno, e se li pongono in tasca, per non abbagliare il mortale che si fa innanzi.
Tasso. Tu dici il vero pur troppo. Ma non ti pare egli cotesto un gran peccato delle donne; che alla prova, elle ci riescano così diverse da quelle che noi le immaginavamo?
Genio. Io non so vedere che colpa s'abbiano in questo, d'esser fatte di carne e sangue, piuttosto che di ambrosia e nettare. Qual cosa del mondo ha pure un'ombra o una millesima parte della perfezione che voi pensate che abbia a essere nelle donne? E anche mi pare strano, che non facendovi maraviglia che gli uomini sieno uomini, cioè creature poco lodevoli e poco amabili; non sappiate poi comprendere come accada, che le donne in fatti non sieno angeli.
Tasso. Con tutto questo, io mi muoio dal desiderio di rivederla, e di riparlarle.
Genio. Via, questa notte in sogno io te la condurrò davanti; bella come la gioventù; e cortese in modo, che tu prenderai cuore di favellarle molto più franco e spedito che non ti venne fatto mai per l'addietro: anzi all'ultimo le stringerai la mano; ed ella guardandoti fisso, ti metterà nell'animo una dolcezza tale, che tu ne sarai sopraffatto; e per tutto domani, qualunque volta ti sovverrà di questo sogno, ti sentirai balzare il cuore dalla tenerezza.
Tasso. Gran conforto: un sogno in cambio del vero.
Genio. Che cosa è il vero?
Tasso. Pilato non lo seppe meno di quello che lo so io.
Genio. Bene, io risponderò per te. Sappi che dal vero al sognato, non corre altra differenza, se non che questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che quello non può mai.
Tasso. Dunque tanto vale un diletto sognato, quanto un diletto vero?
Genio. Io credo. Anzi ho notizia di uno che quando la donna che egli ama, se gli rappresenta dinanzi in alcun sogno gentile, esso per tutto il giorno seguente, fugge di ritrovarsi con quella e di rivederla; sapendo che ella non potrebbe reggere al paragone dell'immagine che il sonno gliene ha lasciata impressa, e che il vero, cancellandogli dalla mente il falso, priverebbe lui del diletto straordina rio che ne ritrae. Però non sono da condannare gli antichi, molto più solleciti, accorti e industriosi di voi, circa a ogni sorta di godimento possibile alla natura umana, se ebbero per costume di procurare in vari modi la dolcezza e la giocondità dei sogni; né Pitagora è da riprendere per avere interdetto il mangiare delle fave, creduto contrario alla tranquillità dei medesimi sogni, ed atto a intorbidarli;(2) e sono da scusare i superstiziosi che avanti di coricarsi solevano orare e far libazione a Mercurio
conduttore dei sogni, acciò ne menasse loro di quei lieti; l'immagine del quale tenevano a quest'effetto intagliata in su' piedi delle lettiere.(3) Così, non trovando mai la felicità nel tempo della vigilia, si studiavano di essere felici dormendo: e credo che in parte, e in qualche modo, l'ottenessero; e che da Mercurio fossero esauditi meglio che dagli altri Dei.
Tasso. Per tanto, poiché gli uomini nascono e vivono al solo piacere, o del corpo o dell'animo; se da altra parte il piacere è solamente o massimamente nei sogni, converrà ci determiniamo a vivere per sognare: alla qual cosa, in verità, io non mi posso ridurre.
Genio. Già vi sei ridotto e determinato, poiché tu vivi e che tu consenti di vivere. Che cosa è il piacere?
Tasso. Non ne ho tanta pratica da poterlo conoscere che cosa sia.
Genio. Nessuno lo conosce per pratica, ma solo per ispeculazione: perché il piacere è un subbietto speculativo, e non reale; un desiderio, non un fatto; un sentimento che l'uomo concepisce col pensiero, e non prova; o per dir meglio, un concetto e non un sentimento. Non vi accorgete voi che nel tempo stesso di qualunque vostro diletto, ancorché desiderato infinitamente, e procacciato con fatiche e molestie indicibili; non potendovi contentare il goder che fate in ciascuno di quei momenti, state sempre aspettando un goder maggiore e più vero, nel quale consista insomma quel tal piacere; e andate quasi riportandovi di continuo agl'istanti futuri di quel medesimo diletto? Il quale finisce sempre innanzi al giungere dell'istante che vi soddisfaccia; e non vi lascia altro bene
che la speranza cieca di goder meglio e più veramente in altra occasione, e il conforto di fingere e narrare a voi medesimi di aver goduto, con raccontarlo anche agli altri, non per sola ambizione, ma per aiutarvi al persuaderlo che vorreste pur fare a voi stessi. Però chiunque consente di vivere, nol fa in sostanza ad altro effetto né con altra utilità che di sognare; cioè credere di avere a godere, o di aver goduto; cose ambedue false e fantastiche.
Tasso. Non possono gli uomini credere mai di godere presentemente?
Genio. Sempre che credessero cotesto, godrebbero in fatti. Ma narrami tu se in alcun istante della tua vita, ti ricordi aver detto con piena sincerità ed opinione: io godo. Ben tutto giorno dicesti e dici sinceramente: io godrò; e parecchie volte, ma con sincerità minore: ho goduto. Di modo che il piacere è sempre o passato o futuro, e non mai presente.
Tasso. Che è quanto dire è sempre nulla.
Genio. Così pare.
Tasso. Anche nei sogni.
Genio. Propriamente parlando.
Tasso. E tuttavia l'obbietto e l'intento della vita nostra, non pure essenziale ma unico, è il piacere stesso; intendendo per piacere la felicità, che debbe in effetto esser piacere; da qualunque cosa ella abbia a procedere.
Genio. Certissimo.
Tasso. Laonde la nostra vita, mancando sempre del suo fine, è continuamente imperfetta: e quindi il vivere è di sua propria natura uno stato violento.
Genio. Forse.
Tasso. Io non ci veggo forse. Ma dunque perché viviamo noi? voglio dire, perché consentiamo di vivere?
Genio. Che so io di cotesto? Meglio lo saprete voi, che siete uomini.
Tasso. Io per me ti giuro che non lo so.
Genio. Domandane altri de' più savi, e forse troverai qualcuno che ti risolva cotesto dubbio.
Tasso. Così farò. Ma certo questa vita che io meno, è tutta uno stato violento: perché lasciando anche da parte i dolori, la noia sola mi uccide.
Genio. Che cosa è la noia?
Tasso. Qui l'esperienza non mi manca, da soddisfare alla tua domanda. A me pare che la noia sia della natura dell'aria: la quale riempie tutti gli spazi interposti alle altre cose materiali, e tutti i vani contenuti in ciascuna di loro; e donde un corpo si parte, e altro non gli sottentra, quivi ella succede immediatamente. Così tutti gl'intervalli della vita umana frapposti ai piaceri e ai dispiaceri, sono occupati dalla noia. E però, come nel mondo materiale, secondo i Peripatetici, non si dà vòto alcuno; così nella vita nostra non si dà vòto; se non quando la mente per qualsivoglia causa intermette l'uso del pensiero. Per tutto il resto del tempo, l'animo, considerato anche in se proprio e come disgiunto dal corpo, si trova contenere qualche passione; come quello a cui l'essere vacuo da ogni piacere e dispiacere, importa essere pieno di noia, la quale anco è passione, non altrimenti che il dolore e il diletto.
Genio. E da poi che tutti i vostri diletti sono di materia simile ai ragnateli; tenuissima, radissima e trasparente; perciò come l'aria in questi, così la noia penetra in quelli da ogni parte, e li riempie. Veramente per la noia non credo si debba intendere altro che il desiderio puro della felicità; non soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere. Il buon desiderio, come dicevamo poco innanzi, non è mai soddisfatto; e il piacere
propriamente non si trova. Sicché la vita umana, per modo di dire, è composta e intessuta, parte di dolore, parte di noia; dall'una delle quali passioni non ha riposo se non cadendo nell'altra. E questo non è tuo destino particolare, ma comune di tutti gli uomini.
Tasso. Che rimedio potrebbe giovare contro la noia?
Genio. Il sonno, l'oppio, e il dolore. E questo è il più potente di tutti; perché l'uomo mentre patisce, non si annoia per niuna maniera.
Tasso. In cambio di cotesta medicina, io mi contento di annoiarmi tutta la vita. Ma pure la varietà delle azioni, delle occupazioni e dei sentimenti, se bene non ci libera dalla noia, perché non ci crea diletto vero, contuttociò la solleva ed alleggerisce. Laddove in questa prigionia, separato dal commercio umano, toltomi eziandio lo scrivere, ridotto a notare per passatempo i tocchi dell'oriuolo, annoverare i correnti, le fessure e i tarli del palco, considerare il mattonato del pavimento, trastullarmi colle farfalle e coi moscherini che vanno attorno alla stanza, condurre quasi tutte le ore a un modo; io non ho
cosa che mi scemi in alcuna parte il carico della noia.
Genio. Dimmi: quanto tempo ha che tu sei ridotto a cotesta forma di vita?
Tasso. Più settimane, come tu sai.
Genio. Non conosci tu dal primo giorno al presente, alcuna diversità nel fastidio che ella ti reca?
Tasso. Certo che io lo provava maggiore a principio: perché di mano in mano la mente, non occupata da altro e non isvagata, mi si viene accostumando a conversare seco medesima assai più e con maggior sollazzo di prima, e acquistando un abito e una virtù di favellare in se stessa, anzi di cicalare, tale, che parecchie volte mi pare quasi avere una compagnia di persone in capo che stieno ragionando, e ogni menomo soggetto che mi si appresenti al pensiero, mi basta a farne tra me e me una gran diceria.
Genio. Cotesto abito te lo vedrai confermare e accrescere di giorno in giorno per modo, che quando poi ti si renda la facoltà di usare cogli altri uomini, ti parrà essere più disoccupato stando in compagnia loro, che in solitudine. E quest'assuefazione in sì fatto tenore di vita, non credere che intervenga solo a' tuoi simili, già consueti a meditare; ma ella interviene in più o men tempo a chicchessia. Di più, l'essere diviso dagli uomini e, per
dir così, dalla vita stessa, porta seco questa utilità; che l'uomo, eziandio sazio, chiarito e disamorato delle cose umane per l'esperienza; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a mirarle da lungi, donde elle paiono molto più belle e più degne che da vicino, si dimentica della loro vanità e miseria; torna a formarsi e quasi crearsi il mondo a suo modo; apprezzare, amare e desiderare la vita; delle cui speranze, se non gli è tolto o il potere o il confidare di restituirsi alla società degli uomini, si va nutrendo e dilettando, come egli soleva a' suoi primi anni. Di modo che la solitudine fa quasi l'ufficio della gioventù; o certo ringiovanisce l'animo, ravvalora e rimette in opera l'immaginazione, e rinnuova nell'uomo esperimentato i beneficii di quella prima inesperienza che tu sospiri. Io ti lascio; che veggo che il sonno ti viene entrando; e me ne vo ad apparecchiare il bel sogno che ti ho promesso. Così, tra sognare e fantasticare, andrai consumando la vita; non con altra utilità che di consumarla; che questo è l'unico frutto che al mondo se ne può avere, e l'unico intento che voi vi dovete proporre ogni mattina in sullo svegliarvi. Spessissimo ve la conviene strascinare co' denti: beato quel dì che potete o
trarvela dietro colle mani, o portarla in sul dosso. Ma, in fine, il tuo tempo non è più lento a correre in questa carcere, che sia nelle sale e negli orti quello di chi ti opprime. Addio.
Tasso. Addio. Ma senti. La tua conversazione mi riconforta pure assai. Non che ella interrompa la mia tristezza: ma questa per la più parte del tempo è come una notte oscurissima, senza luna né stelle; mentre son teco, somiglia al bruno dei crepuscoli, piuttosto grato che molesto. Acciò da ora innanzi io ti possa chiamare o trovare quando mi bisogni, dimmi dove sei solito di abitare.
Genio. Ancora non l'hai conosciuto? In qualche liquore generoso.
DIALOGO GALANTUOMO E MONDO
Di tutto, eziandio che con gravissime ed estreme minacce vietato, si può al mondo non pagar pena alcuna. De'
tradimenti, delle usurpazioni, degl'inganni, delle avarizie, oppressioni, crudeltà, ingiustizie, torti, oltraggi,
omicidi, tirannia ec. ec. bene spesso non si paga pena;
spessissimo ancora se n'ha premio, o certo utilità. Ma
inesorabilmente punita, e a nulla utile e sempre dannosa,
e tale che mai non ischiva il suo castigo, mai non resta
senza pena, è la dabbenaggine (coglioneria) e l'esser galantuomo, ch'altrettanto è a dire.
G. Come desidera Vostra Eccellenza ch'io la serva?
M. Chi sei tu?
G. Sono un povero disgraziato.
M. Incominciamo male. I disgraziati io non li posso
vedere.
G. Ma V. E. è tanto compassionevole.
M. Tutto l'opposto. Chi diavolo ti ha dato ad intendere che nel mondo si trova compassione?
G. V. E. mi scusi. Me l'avevano detto i poeti e i romanzieri.
M. Già me lo figurava. Lasciali cantare ai bambocci.
Ho un barlume nella memoria, ch'io da ragazzo e da
giovanotto avessi compassione; ma è lunghissimo tempo che i mali altrui mi commuovono quanto un predicatore italiano. è gran tempo che la sfortuna non fa più
335
fortuna, se non quando è falsa ec. e chi è sventurato lo è
per davvero e non per giuoco. Ma tu non sei mica bello.
G. V. E. dice bene.
M. Dico bene senza fallo: questo già s'intende. Ma in
somma, disgraziato e non bello. Figlio mio, non penso
di poterti giovare a niente.
G. Ma s'accerti Vostra Eccellenza che ho bonissimo
cuore, e mi sono sempre esercitato nella virtù.
M. Peggio che peggio. Tu vuoi morir disperato, e appiccarti da te stesso ec. ec. (segua un discorso intorno al
danno dell'aver buon cuore, e sensibilità). Sei nobile?
G. Eccellenza sì.
M. Questo va bene. Ricco?
G. E come, Eccellenza, se sono stato sempre galantuomo?
M. Via, questo non farà caso. Quando sarai divenuto
un furfante, arricchirai. La nobiltà, figliuolo, è una gran
bella cosa, e perché sei nobile, voglio vedere d'aiutarti,
sicché ti prendo al mio servizio.
G. V. E. mi comandi in che maniera io mi debba regolare.
M. Figlio mio, per condursi bene ci vuole un poco
d'arte.
G. V. E. si compiaccia di credermi, ch'io non manco
d'ingegno, anzi tutti mi dicono ch'io n'ho moltissimo, e
se ne fanno maraviglia.
M. Questo non rileva. (Il punto non consiste qui).
Non basta avere ingegno, ma un certo tale ingegno. Se
hai questo, procura di coltivarlo, e non curarti dell'altro.
336
Se questo ti manca, qualunque altro ingegno, fosse anche maggiore che non fu l'ingegno di Omero e di Salomone, non ti può valere a nulla.
G. V. E. mi perdoni. Aveva sentito dire che il vero e
grande ingegno, risplende attraverso qualunque riparo, e
non ostante qualunque impedimento, presto o tardi prevale.
M. Chi te l'ha detto? Qualche antiquario che l'ha imparato dalle iscrizioni, o qualche tarlo che l'ha trovato
scritto nei codici in pergamena? Anticamente lo so ancor io che il fatto stava così come tu dici, ma non dopo
che l'esperienza e l'incivilimento m'hanno trasformato in
un altro da quello di prima. Specchiati in Dante Alighieri, in Cristoforo Colombo, in Luigi Camoens, in Torquato Tasso, in Michele Cervantes, in Galileo Galilei, in
Francesco Quevedo, in Giovanni Racine, in Francesco
Fénélon, in Giacomo Thomson, in Giuseppe Parini, in
Giovanni Melendez, e in cento mila altri. Che se costoro
hanno avuto qualche fama o dopo morti o anche vivendo, questo non leva che non sieno stati infelicissimi, e la
fama poco può consolare in vita e niente dopo morte. E
se vuoi veder di quelli che non sono arrivati neppure
alla fama che cercavano, guarda Chatterton. v. lo Spettatore di Milano, quaderno 68, p. 276. Parte straniera.
(Qui va il nome di un poeta lirico tedesco morto giovane
di grandi speranze, vissuto, mi pare, alla corte di Federico II e colpito da un suo motto o altro che gli cagionò
gran pena e forse la morte, odiato da suo padre, che se
ne pentì dopo la sua morte, ec. Mi pare che il nome in337
cominci per G.). Malfil�tre (Chateaubriand Génie etc.
not. 3 de l'Appendice au deux. vol.) e moltissimi altri
che furono d'altissimo ingegno, e morirono senza fama
sul fior degli anni, chi dalla povertà, chi dalla disperazione, e oggi niuno se ne ricorda. E quanti altri sono vissuti anche lungamente, e hanno scritto o fatto cose molto più degne d'immortalità che non sono infinite altre
notissime e famosissime. E contuttociò perché la fortuna
ed io non gli abbiamo aiutati, non hanno avuto nessun
grido, e non si parlerà mai di loro, come se non fossero
mai stati. Dimmi un poco: pizzichi niente di letterato?
G. Eccellenza, posso dire che da che vivo non ho fatto altro che studiare, tanto che questo m'ha indebolita e
guasta la complessione e la salute del corpo.
M. Male malone, Hai sprecato il tempo, la fatica e la
spesa. Tutto lo studio fa conto d'averlo gittato, e il danno
che ti resta lo porterai gratis per amore del diavolo. Non
riprendo che vogli professar dottrina e letteratura, e procacciarti onore e fama con questo mezzo. Anche questo
giova a segnalarsi fra la gente, e farsi riverire dalla moltitudine ed arrivare a molti fini. Ma non si conseguisce
mica per via dello studio, anzi non ci bisogna studio, se
non pochissimo. Senti quello che farai per l'avanti.
Stringerai conoscenza e amicizia con una buona quantità di letterati, non importa che sieno veri o falsi: basta
che abbiano un certo nome. Qualunque te ne capiti, sia
pur meschinissimo, non lo trascurare, e fattelo subito
amico, perché il gran chiasso non lo può fare altro che la
moltitudine delle persone. Loderai pubblicamente le
338
opere loro a oggetto ch'essi ti rendano il contraccambio:
e di questo non aver dubbio, perché la repubblica letteraria è più giusta assai di tutte le altre repubbliche o reggimenti della terra, e non si governa a un dipresso con
altre leggi che di retribuzione. Ti farai scrivere a quante
accademie potrai, e da principio farai mostra de' titoli
onorifici, nel frontespizio de' tuoi libri, e comunque ti si
darà la congiuntura: poi quando tutti gli avranno imparati a memoria gli tralascerai facendo vista di non curargli e nascondergli, acciò che gli altri t'abbiano per magnanimo. Scrivendo e stampando, scriverai cose che
piacciano alle donne, ai cavalieri, in somma a quelli che
stanno al mio servizio, e le stamperai splendidamente in
bella carta e caratteri, con figurine incise, legature galanti, e cose tali. Quando la prima edizione non avesse
spaccio, ne farai fare un'altra dicendo che la prima è divenuta rara, e non mentirai, perché infatti non si troverà
se non presso pochissimi, vale a dire i librai. E assicurati
che la seconda edizione farà più fortuna della prima. Lo
stile di voi altri italiani già si sa che dev'esser francese; e
per buona ventura non sapete scrivere altrimenti, quando anche la lingua che adoperate fosse mera italiana, o
piuttosto vi paresse. Te la intenderai per lo meno con
tutti quanti i giornalisti della tua nazione, e li pagherai
secondo che ti loderanno. Poniamo caso che tu abbia
pubblicato un poema che vaglia all'incirca quanto il libro di Bertoldo, o quanto una canzone arcadica o frugoniana, o quanto i versi dell'Algarotti del Bettinelli, del
Bondi, o simili. Se diranno che non cede alla Gerusa339
lemme, pagherai un tanto. Se lo metteranno coll'Eneide,
tanto di più; se l'anteporranno all'Iliade, tanto di più, e
così discorrendo.
G. Ma, Eccellenza, tutti dicono che questi artifizi e
queste frodi, sono rifugi dell'ignoranza, e del poco merito ec. e che questo non è il modo di arrivare alla fama
ec.
M. Gaglioffo, non sai che altro è quello che si dice,
altro quello che si fa? E da lunghissimo tempo non c'è
memoria di (e da tempo immemorabile non s'è trovata)
persona che abbia conformato i fatti alle parole? Governati com'io ti dico, e non cercar altro. Quanto ai premi
che propongono le accademie, ti racconterò una storiella
antica. Quando Alessandro Macedone stava in punto di
morte, vennero i suoi Generali e gli domandarono a chi
lasciasse il regno. Rispose Alessandro, al più forte. La
stessa cosa fanno tutte le accademie, e tutti coloro che
propongono premi letterari. Sicché volendo concorrere a
qualche premio, non guardare se tu sei più degno degli
altri, ma più forte. Se non sei più forte, quando anche
fossi una musa, non venire in competenza nemmeno
colle ranocchie, perché tu sarai fischiato, e le ranocchie
andranno intorno colla medaglia (corona). Con questa
considerazione ti dovrai regolare in qualunque altra concorrenza letteraria. Questo sia detto in ordine alla letteratura. Adesso torniamo al proposito della maniera che
tu mi devi servire. Primieramente ficcati bene in testa
che tu dovrai contenerti e vivere come fanno tutti gli altri.
340
G. In ogni cosa?
M. In ogni cosa di fuori; e di dentro più che potrai,
vale a dire che devi porre ogni studio a conformare non
solamente i detti i fatti e le maniere, ma anche i geni le
opinioni e le massime tue con quelle degli altri. Pensa
che in chiunque mi serve io non voglio nessunissima
cosa straordinaria a nessunissimo patto, e se qualcuno è
straordinario o singolare per natura, bisogna che si corregga se vuol piacere a me.
G. V. E. mi perdoni. Ma che bellezza o piacere troveremo quando tutti saranno uguali, e diranno e faranno le
stesse cose?
M. A questo non devi pensare. Non ci dev'essere un
uomo diverso da un altro, ma tutti debbon essere come
tante uova, in maniera che tu non possa distinguere questo da quello. E chiunque si lascerà distinguere sarà
messo in burla ec.
G. Sicché posto ch'io mi trovassi in un paese dove
tutti fossero ciechi da un occhio, bisognerebbe ch'io me
ne cavassi uno per non lasciarmi distinguere (per appareggiarmi cogli altri).
M. Questo sarebbe il dover tuo. Ma lasciamo i casi
immaginari.
G. Certo che se Vostra Eccellenza andasse a un teatro
di burattini, e che tutti i burattini fossero vestiti d'una
forma, e si movessero d'una maniera, e che facessero dir
loro le stesse cose, V. E. s'attedierebbe mortalmente ec.
ec. e pretenderebbe che gli restituissero il danaro che
avesse pagato. Nessuna cosa è più necessaria alla vita,
341
della varietà ec. perch'è la sola medicina della noia che
segue tutti i piaceri.
M. Tu dunque presumi di servire il Mondo, e temi la
noia? Non sai che chiunque mi serve, si può dire che
non faccia altro che annoiarsi? E che tutti i beni ch'io
posso dare si risolvono nella noia? Sicché cercando i
miei benefizi e conseguendoli, non avrai altra compagna
né altra meta che questa? Non accade ora come quando
ogni cosa umana era piena di vita, di movimento, di varietà, d'illusioni, in maniera che la gente non s'annoiava.
Ma oggidì non avere altra speranza che d'attediarti in
eterno, e di morire felicemente a ogni tratto, perch'io
non voglio più vita né strepiti né disordini né mutazioni
di cose. L'ignorante e il fanciullo non s'annoia, perch'è
pieno d'illusioni, ma il savio conoscendo la verità d'ogni
cosa, non si pasce d'altro che di noia.
G. Ma se V. E. odia lo straordinario, odierà quasi tutte
le buone e belle e grandi azioni, e se dovremo far sempre quello che fanno gli altri; non potrà stare che non
operiamo tutto giorno contro natura, non solo perché
dovremo adattarci alle inclinazioni altrui, ma perché la
massima parte degli uomini opera a ritroso della sua
stessa natura.
M. Che diavolo è questo che mi vieni
ingarbugliando? Che ha da fare il Mondo colla natura?
(Che ho da far io) Sempre che ti sento parlare stimo che
sia risuscitata mia nonna, o di trovarmi ancora in conversazione (compagnia della) colla balia. Siamo ai tempi d'Abramo o dei re pastori, o della guerra troiana? La
342
natura mi fece la scuola da fanciullo, ma ora, come succede spesso in fatto di maestri, è mia somma e capitalissima nemica, e la mia grande impresa è questa di snidarla da qualunque minimo cantuccio, dov'ella sia rannicchiata. Ed oramai son vicino a riuscire, e spero che fra
poco le farò dare un bando generale che la scacci da tutto quanto il genere umano, e non si troverà più vestigio
della natura fra gli uomini.
G. V. E. senza fallo dev'essere amica della ragione.
M. Sì, ma di quella fredda freddissima, e dura durissima come il marmo. A questa sì le voglio bene, povera
vecchia, debole quanto una pulce.
G. è stata sempre così debole, o solamente dopo invecchiata?
M. Sempre da quando nacque. Appena ha forza di
dare il fiato. E non solamente è stata debole, ma ha snervato e snerva chiunque l'ha seguita o la segue. Fo che
tenga una bottega dove una quantità di politici filosofi
ec. ci stanno da garzoni, e lavorano il giorno e la notte a
farmi il sorbetto e altre cose ghiacciate che mi piacciono
sommamente e mi giovano moltissimo.
G. V. E. non ama il caldo?
M. Dio mi scampi dal caldo. Quand'era giovane andava alla bottega della natura dove stavano i poeti (ma
quei poeti d'allora) e gli altri scrittori magnanimi, che
tutti facevano all'amore con lei, perch'è stata sempre una
bellissima ragazza. E questi mi davano certe bolliture e
certi spiriti che mi mettevano il fuoco nelle ossa. Il fatto
sta ch'io veniva nerboruto, svelto, leggero, asciutto
343
come un tisico, non istava mai fermo, faticava e sudava
come una bestia, sognava mille scempiaggini, e non credo che passassi due giornate nello stesso modo. Finalmente ho conosciuta la verità delle cose, e pigliato il
vero partito. Non mi levo più da sedere, non vorrei muovere un dito per tutto l'oro della terra, non fo più niente,
ma in vece penso tutto giorno, e trovo cento belle cose;
e di tutte le mie giornate non c'è una che differisca dalla
precedente. Così godo una salute perfettissima, ingrasso
sempre più, anzi mi si gonfia sino la pancia e le gambe.
Certa gente malinconica grida ch'io scoppierò, ma prima
essi morranno di mal sottile, o s'infilzeranno il cuore.
Dunque la prima cosa ch'io voglio è che tu debba far
tutto quello che fanno gli altri. La seconda, che ti debba
scordare affatto della natura. Vediamo adesso se tu capisci niente di quello ch'io ti dico. In materia de' tuoi pregi
o difetti come pensi di averti a contenere verso gli altri?
G. Dissimulare i pregi ch'io stimo d'avere; condurmi
sempre modestamente; e se ho qualche difetto o corporale o intellettuale, confessarlo in maniera che gli altri
mi compatiscano, e in somma non arrogarmi nessuna
cosa, massimamente dove so di non aver merito.
M. Bravo bravissimo. Va via che sarai fortunato come
il cane in chiesa. M'avvedo bene che la porta del tuo
cervelluccio è più stretta del bocchino di una smorfiosa,
e a volere che gl'insegnamenti miei ci possano entrare,
bisogna ch'io ti parli più chiaro del mezzogiorno. Dunque sappi che quando io fui d'età fra maturo e vecchio, e
lasciai la bottega e i cibi della natura per quelli della ra344
gione, mi prese una malattia simile a quella che Dante
ec. Perché la testa e le gambe mi si cominciarono a voltare in maniera che la faccia venne dove stava la nuca, e
il ginocchio dove stava l'argaletto (parola falsa), sicché
il davanti restò di dietro, e quello che tu vedi non è il
petto né il ventre, ma la schiena e il sedere. E perciò non
posso più camminare altro che a ritroso, e quelli che gridano che il mondo è tutto il rovescio di quello che dovrebbe, si maravigliano scioccamente. Allora bench'io
guardassi e considerassi il mio cammino assai più di prima, siccome lo guardava di traverso, e in un modo pel
quale io non era fatto, inciampava, cadeva, errava ad
ogni passo. Così finalmente mi risolsi di mettermi a sedere, e non muovermi più ec. Sappi ch'io son fatto eunuco, sebbene ancora libidinoso. Questo dunque ti serva di
regola per giudicare e far giusto concetto della natura
delle cose umane e de' tuoi doveri nella società; e in
ogni caso, in cui per essere novizio, dubiterai della maniera di contenerti o di pensare, appigliarti sempre al
contrario di quello che ti parrebbe naturalmente. Come
nel nostro proposito. Naturalmente andrebbe fatto come
tu dici. Dunque va fatto il rovescio. Negli uomini non si
trova più compassione, sicché non vale il confessare i
propri difetti o svantaggi. Neanche si stimano più i pregi
veri, se non se ne fa gran chiasso, sicché la modestia
non può far altro che danno. E se chi li possiede non se
ne mostra persuasissimo, è come se non gli avesse. La
prima regola in questo particolare è di fornirsi di una
buona dose di presunzione, e mostrare a tutti di tenersi
345
per una gran cosa. Perché se gli altri da principio ne
sono ributtati, a poco a poco ci si avvezzano, e cominciano a credere che tu abbi ragione. Ciascuno s'adopra a
più potere che il vicino sia più basso di lui. Sicché il vicino bisogna che faccia altrettanto. Se è più basso da
vero, non s'aspetti nessunissima discrezione quando voglia cedere e confessare che il fatto sta così. Anzi tanto
più bisogna che s'adopri per pareggiarsi agli altri, e coprire il vero, e farsi stimare, e conseguire quello che non
merita. E perciò conviene che l'ignorante s'arroghi dottrina, il plebeo nobiltà, il povero ricchezza, il brutto bellezza, il vecchio gioventù, il debole forza, il malato sanità, e via discorrendo. Tutto quello che tu cederai devi
stimare che sia perduto intieramente, e non ti verrà nessun frutto dall'averle ceduto. Che se da te medesimo ti
porrai mezzo dito più basso degli altri in qualunque
cosa, gli altri ti cacceranno un braccio più giù. Per venire a capo degli uomini ci vuole gran forza di braccia da
fare alle pugna come s'usa in Inghilterra, e gran forza di
polmone da gridare, strepitare, sparlare, bravare minacciare più forte degli altri, e domar gli uomini come si
domano i cavalli e i muli, e come quella povera Badessa, e quella povera educanda che riferisce Tristano
Scendi, trovandosi sole in viaggio, vinsero quel cavallo
restio con una parolaccia che per iscrupolo di coscienza
la dissero mezza per una. E però bisogna far muso tosto,
e buona schiena da portar francamente le bastonate e
non perdersi mai di coraggio, né stancarsi per cosa che
sia: ma proccurare d'aggiustarsi la persona appresso a
346
poco sulla forma di quei trastulli che i ragazzi chiamano
saltamartini, i quali capovolgili, corcali, mettili come
vuoi, sempre tornano in piedi.
G. Ma tutto questo come s'accorda con quanto Vostra
E. mi ha comandato, ch'io debba far tutto quello che
fanno gli altri?
M. Primieramente s'accorda benissimo per mille capi.
Secondariamente non ti ho detto, ch'io non posso più
camminare altro che a ritroso? Laonde se una volta le
contraddizioni non si soffrivano, ora nelle cose mie sono
frequentissime, e quasi tutti i precetti miei contraddicono gli uni agli altri. Resterebbero molte altre cose, ma
toccheremo le principali. Tu saprai quello che fanno le
scimmie quando vogliono passare un fiume, ec. ec. Nella stessa maniera voi altri servitori miei, quando non potete arrivare a qualche fine da voi soli, bisogna che facciate molti insieme una catena come le scimmie.
G. V. E. intende parlare dell'amicizia?
M. Eccoti sempre colle parole antiche e rancide. Saresti proprio al caso di fare il rigattiere o il proposto d'un
museo d'anticaglie. L'amicizia non si trova più, o se
vuoi chiamarla con questo nome, devi sapere ch'è fatta a
uso di quelle fibbie o fermagli che servono ad allacciare
mentre bisogna, e finito il bisogno si slacciano, e spesse
volte si levano via. Così le amicizie d'oggidì. Fatte che
sieno, quand'occorre s'allacciano e stringono: finita l'occorrenza, alle volte si slacciano ma si lasciano in essere,
tanto che volendo si possano riallacciare; altre volte si
levano via del tutto, e ciascuno resta libero e sciolto
347
come per l'addietro. Dal che viene che laddove gli antichi appena stimavano che un uomo sommo potesse trovare un solo amico, oggi per lo contrario un uomo da
nulla ne trova tanti, che sapendo contare tutte le altre
cose che possiede, questi soli non si cura né gli darebbe
l'animo di contarli. Ma senza questa moltiplicità di fermagli non si viene a capo di nessuna cosa. Tuttavia si
danno anche presentemente di quelle amicizie strettissime ed eterne come le antiche, anzi superiori alle antiche, in quanto contengono essenzialmente un principio
ingenito d'indissolubilità. E sono quelle amicizie che
due o tre persone stringono insieme per aiutarsi scambievolmente nelle truffe, tradimenti, ec. in somma in
ogni sorta di malvagità squisita ed eroica. Queste non si
possono sciorre perché ciascheduno teme che l'altro non
divulghi le sue scelleraggini, e perciò è forza che durino
eternamente, e s'abbiano sempre in cura quanto la vita.
Ma queste non sono proprie del volgo ma degli eroi di
questo secolo. E se i poeti non fossero così scimuniti, lascerebbero i Patrocli e i Piladi e i Nisi e gli altri frittumi
antichi, e farebbero argomento di poema e di tragedia
queste amicizie moderne molto più nobili e degne, perché quelle giovavano alla virtù, alle imprese temerarie e
vane, alla patria, e agli altri fantasmi di quei tempi, ma
queste conducono alle vere e grandi utilità della vita.
(Qui seguano alcune parole dove ironicamente si provi che le cose moderne sono adattate alla poesia molto
più delle antiche. E il Mondo si dolga che queste siano
preferite, e quelle altre neglette dai poeti. Si potrà anche
348
introdurre una satira dei romantici, lodandoli di voler
sostituire la freddezza la secchezza e viltà dei soggetti
moderni, al calore, magnanimità, sublimità ec. degli antichi).
(Poi venga un discorso sugl'intrighi, e la necessità
della cabala, e come questa sia quella cosa che governa
il Mondo; sopra l'inutilità anzi dannosità del vero merito
e della virtù).
G. Adesso capisco perché la massima parte, anzi, si
può dire, tutti quelli che da giovani avevano seguita la
virtù ec. entrati al servizio di V. E. in poco tempo mutano registro, e diventano cime di scellerati e lane in chermisino. V. E. mi creda ch'io gl'imiterò in tutto e per tutto, e quanto per l'addietro sono stato fervido nella virtù e
galantuomo, tanto per l'avanti sarò caldo nel vizio.
M. Se avrai filo di criterio. Io voglio che tu mi dica
una cosa da galantuomo per l'ultima volta. A che ti ha
giovato o giova agli uomini la virtù?
G. A non cavare un ragno da un buco. A fare che tutti
vi mettano i piedi sulla pancia, e vi ridano sul viso e dietro le spalle. A essere infamato, vituperato, ingiuriato,
perseguitato, schiaffeggiato, sputacchiato anche dalla
feccia più schifosa, e dalla marmaglia più codarda che si
possa immaginare.
M. Guarda mo se torna meglio a lasciarsi scorticare e
sbranare per amor di una cieca e sorda che non vede e
non sente, e non ti ringrazia, e non s'accorge né punto né
poco di quello che tu soffri per cagion sua, piuttosto che
a servir uno, il quale quando tu sappia dargli nel genio,
349
non può fare che non ti paghi largamente, e no ti soddisfaccia in quasi tutte le cose che potrai desiderare.
G. Sappia V. E. che s'io fossi stato sempre vizioso
non sarei così buono a servirla, com'Ella mi proverà.
Perché quelli che non hanno mai sperimentato il vivere
onesto, non possono avere nella scelleraggine quella
forza ch'ha un povero disgraziato, il quale avendo fatto
sempre bene agli uomini, e seguita la virtù sin dalla nascita, e amatala di tutto cuore, e trovatala sempre inutilissima e sempre dannosissima, alla fine si getta rabbiosamente nel vizio, con animo di vendicarsi degli uomini,
della virtù e di se stesso. E vedendo che se avesse voluto
far bene agli uomini, tutti avrebbero congiurato a
schiacciarlo, si determina di prevenirgli, e di schiacciargli esso in quanto possa.
M. Qual è il tuo nome, ch'io lo metta in lista insieme
cogli altri?
G. Aretofilo Metanoeto al servizio di V. E. Aretofilo
Metanoeto è quanto dire Virtuoso Penitente, cioè della
virtù, come diciamo peccator penitente colui che si pente del vizio.
|